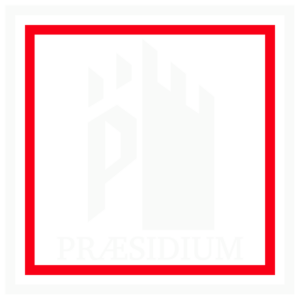Tutti presi dalle vicende del Recovery Fund e annessi e connessi, sembra che qualcuno si sia dimenticato di un altro fattore già critico del tessuto economico italiano e i cui sviluppi, a seguito della crisi del coronavirus, rischiano di essere di portata drammatica.
Il tema è quello degli ingentissimi stock di crediti deteriorati (o NPL, Non Performing Loans, secondo la dizione anglofona), presenti negli attivi bancari. Un po’ di storia per avere un minimo di contezza dell’entità del problema.
Nel 2008, all’alba della crisi finanziaria internazionale, l’insieme dei crediti detenuti dalle banche italiane verso famiglie e imprese con difficoltà ad onorare i propri debiti ammontavano a meno di 90 miliardi, un valore, dato il volume dell’economia italiana, del tutto in linea con quello delle altre nazioni europee.
A seguito della crisi, nel 2011 lo stock aumenta a quasi 200 miliardi, ma, mentre all’estero si interveniva con misure fiscali espansive per contenere lo shock, con la “cura” del governo Monti seguita alla ulteriore crisi del debito sovrano italiano, ovvero quel “consolidamento fiscale volto a distruggere la domanda interna“, come il bocconiano ebbe a dire alla CNN, crebbe in maniera drammatica il tasso di default, sia corporate che retail, in Italia.
Alla fine del 2015 si toccava il picco di 350 miliardi (circa il 20% del PIL) di crediti deteriorati detenuti dalle banche.
Ovviamente l’austerità, l’enorme impoverimento della domanda e la riduzione dei volumi del mercato interno – tutte misure benedette e pretese da BCE e UE – hanno così cominciato a gravare in maniera pesantissima sul nostro sistema bancario, che pure si presentava, a fine 2008, come uno dei pochi scampati alla crisi dei derivati per la scarsa esposizione in strumenti tossici delle nostre banche.
La risposta delle banche, sollecitata dalla vigilanza nazionale di Banca d’Italia, come da quella europea di BCE, fu rivolta a cercare di sbarazzarsi di questi macigni sui propri conti avviando operazioni di cessioni di portafogli e cartolarizzazioni. Iniziava così l’ondata di vendite a fondi e investitori istituzionali di posizioni di credito di dubbio recupero.
La BCE, forte del proprio ruolo all’interno del Single Supervisory Mechanism – ossia il Meccanismo di Vigilanza Unico andatosi a formare a partire dal 2014 e che fa della BCE, al di sopra delle istituzioni nazionali, il regolatore unico e diretto delle banche di dimensioni medio-grandi (di fatto, di tutto il sistema bancario) – non ha mancato di dare il proprio contributo distruttivo al processo.
Contributo che invece è mancato per quanto concerne l’enorme massa di titoli tossici, titoli derivati e titoli finanziari non quotati di dubbia valorizzazione presenti nei bilanci delle banche francesi e tedesche.
Giusto per dare un’idea del fenomeno, prima di ritornare agli affari di casa nostra: le banche tedesche nel 2019 (ben 11 anni dopo la crisi dei derivati) continuavano ad avere un 30% dei propri bilanci costituiti da titoli valutati al fair value contro il 16% delle banche italiane. Di questi, il 65% dei titoli italiani è costituito da titoli quotati su mercati regolamenti (per i quali, quindi, non sussistono incertezze circa il criterio di valorizzazione), percentuale che scende al 22% per la Germania. Significa che circa il 20% dei bilanci tedeschi sono costituiti da titoli finanziari di dubbia valorizzazione. Significa che forse, se Deutsche Bank macina miliardi di perdite, mentre le sue principali concorrenti italiane, pur in cattive acque, fanno comunque utili e dividendi, un po’ di polvere sotto il tappeto ci sarà ancora.
Non di questo avviso è stata negli anni l’Eurotower di Francoforte. La vigilanza della BCE ha sempre puntato solo e unicamente il faro sul tema dei crediti deteriorati e non su quello della finanza tossica. In questo senso, il primo passo fu la pubblicazione nel marzo 2017 delle ‘NPL Guidance’, con termini sempre più stringenti per le banche in tema di gestione dei portafogli di crediti deteriorati. Di più, la BCE si studiò di presentare un Addendum alla sua Guidance il cui contenuto era veramente dirompente.
Nel famigerato Addendum, la BCE introduceva il principio del ‘calendar provisioning’, ossia richiedeva alle banche di svalutare i crediti deteriorati, tutti i crediti deteriorati, del 100% (entro 7 anni per i crediti ipotecari, entro 2 anni per i crediti chirografari). La richiesta è di inusitata violenza, anche perché irrispettosa della sottocategorizzazione che esiste nel mondo del credito deteriorato.
Un conto sono i crediti in sofferenza, dove per “sofferenza” si intende un credito vantato verso un’azienda che ha perso la continuità aziendale, oppure un credito per il cui recupero si è passati alla fase giudiziale, oppure sono in corso procedimenti di escussione di garanzie, procedure fallimentari, etc…
Un altro, invece, come si può facilmente comprendere, sono i crediti con semplici casi di sconfino o che sono classificati come inadempienze probabili (unlikely to pay o UTP), che risultano essere crediti verso aziende o debitori finanziariamente ancora ‘vivi’, con ritardi nei pagamenti che possono però affrontare un efficace processo di ristrutturazione e riprendere, in maniera totale o quantomeno parziale, a sostenere i pagamenti a servizio del debito.
Di tutto ciò la BCE non tenne conto e pensò bene di applicare le richieste di svalutazione, con annesse previsioni di perdite superiori ai valori di presumibile realizzo, in maniera indifferenziata.
Bisogna riconoscere che in quel frangente, l’allora Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, aprì una battaglia per limitare le richieste della BCE. L’argomento, corretto, era che la BCE nell’ambito del proprio mandato poteva fornire solo “aspettative di vigilanza” e non imporre una nuova regolamentazione, onere in carico alla triade (sic) Commissione-Parlamento-Consiglio. La richiesta fatta alla BCE era dunque quella di correggere il tiro e allungare i tempi di applicazione del calendar provisioning e soprattutto di limitarne l’applicabilità ai nuovi flussi di NPL (non quindi ai 350 mld di stock già esistente).
La battaglia fu ovviamente persa e in un sistema come quello europeo fondato sull’autocefalia delle varie autorità non poteva che essere diversamente. La BCE, dopo aver dato il contentino di aver allungato di 2 anni i termini massimi di applicazione del calendar provisioning e aver accettato che la regolamentazione europea recepisse il principio per i nuovi flussi, si fece comunque forte del proprio mandato insindacabile di unica autorità di vigilanza prudenziale sul sistema bancario.
Nel mandato di vigilanza prudenziale, la BCE verifica la solidità di ogni banca, caso per caso, che è sottoposta al proprio controllo e invia poi delle raccomandazioni specifiche con interventi correttivi che la banca deve seguire in caso di riscontrate anomalie. Il processo è quello del cosiddetto “secondo pilastro” di Basilea III (il quadro di accordi internazionali in tema di vigilanza bancaria), ovvero il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).
La BCE accettava cioè che per gli stock di crediti deteriorati già esistenti non si applicassero le proprie richieste in maniera generalizzata, ma solo banca per banca qualora fosse ritenuto necessario.
Stranamente però fu ritenuto necessario per tutte le banche italiane, o meglio, quasi tutte, visto che a scampare allo SREP furono solo la BNL del gruppo francese BNP Paribas e la ex Cariparma acquisita dalla sempre francese Crédit Agricole. Ovviamente, che l’allora responsabile della vigilanza BCE fosse la francese Danièle Nouy è stato solamente un elemento fortuito e casuale nella determinazione delle banche da esentare…
A tutto ciò si è andata sommando, fida gregaria, l’attività dell’EBA, l’Autorità Bancaria Europea, che ha il compito di definire “standard tecnici” per l’apparato di vigilanza. Come maggiore contributo dell’EBA, negli ultimi tempi, si è avuta la nuova definizione di “default“, che sarà obbligante dal 1 gennaio 2021.
In pratica, la nuova definizione rimuove tutta una serie di paletti e margini di tolleranza che si potevano concedere ad un debitore prima che il sistema bancario fosse obbligato a classificarlo come ‘deteriorato’. In precedenza, si aveva un margine del 5%, ossia se un’azienda su un debito totale di 1.000.000 aveva rate scadute per 40.000, poteva ancora essere considerata in bonis dalla banca, in quanto si considerava che l’entità dello scaduto totale non fosse ancora significativa per avviare un processo di classificazione.
L’EBA ha provveduto ad abbassare la soglia all’1% oltre che definire anche delle soglie in valore assoluto: 100 euro per la clientela retail, 500 euro per quella corporate (in poche parole, zero tolleranza).
A fronte di tutto ciò, il sistema bancario italiano ha trovato nelle cessioni di miliardi di portafogli di crediti deteriorati l’unica ancora di salvezza. Se il credito, vista la regolamentazione opprimente, non è più gestibile, tanto vale cederlo ad un soggetto che è libero da quella regolamentazione e liberare così il proprio bilancio.
Identificare le cessioni e le cartolarizzazioni di portafoglio quali vie maestre per la risoluzione della crisi, ci aveva d’altra parte già pensato la BCE, che coerentemente lo scriveva a chiare lettere nelle sue NPL Guidance.
Dal picco di quasi 350 mld detenuti a fine 2015, le banche italiane sono scese ad oggi sotto i 150 miliardi, vicine a livelli pre-crisi. Il più di questa riduzione tuttavia, questa montagna di 200 miliardi, ovvero un pezzo importante dell’economia, dell’industria, dell’impresa italiana, non risulta essere ritornato in bonis, ma risulta semplicemente ceduto dalle banche a diversi soggetti – fondi, servicer di crediti, veicoli di cartolarizzazione, quasi sempre detenuti da investitori stranieri, privi di licenza bancaria e spesso neanche europei, ma americani e inglesi, ossia totalmente svincolati dal pachiderma della vigilanza europea.
Questi investitori, ovviamente, comprano a sconto dalle banche italiane i crediti di cui queste hanno necessità di disfarsi e, cercando di massimizzarne il ritorno dai debitori, trasferiscono quindi i flussi finanziari in entrata ai finanziatori che hanno pagato la banca per realizzare la cessione.
Si crea così un meccanismo in cui, alla fine, in nome della solidità del sistema bancario, mentre il mercato interno è in crisi ed è in crisi il settore della produzione reale, si drena ulteriormente ricchezza dall’Italia e la si trasferisce all’estero.
Il meccanismo, che, nel bene o nel male, sembrava ormai aver esaurito il suo ciclo espansivo nel periodo 2015-2020, rischia di ripetersi nel mondo post Covid con un’ondata di nuove aziende e famiglie classificate come deteriorate, molte delle quali, per di più, solo per l’applicazione dall’1 gennaio della nuova normativa EBA.
Che effetti può avere il combinato disposto BCE-EBA-Covid sul nostro settore bancario? Siamo sicuri che qualcuno a Roma tra Montecitorio e Palazzo Chigi sia abbastanza cosciente di queste tematiche? Siamo sicuri che BCE e UE siano istituzioni intenzionate a fare i nostri interessi?