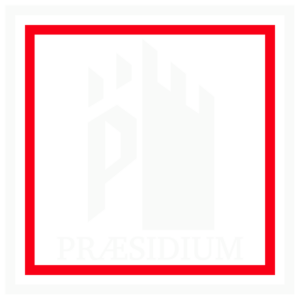Täterschuld.
Con questa espressione, giuristi tedeschi a cavallo fra gli anni Trenta e Quaranta definirono un criterio di responsabilità basato non già sul “fatto” commesso, cioè una manifestazione esteriore, una apprezzabile modifica del mondo sensibile, bensì sull’atteggiamento, la mentalità, la tendenza del reo, di cui il “fatto” non rappresenta che il riflesso.
“Colpa d’autore”, fu battezzata in Italia questa teoria. Ne possiamo ritrovare delle applicazioni nelle c.d. misure di prevenzione, applicate dalle questure contro soggetti ritenuti socialmente pericolosi (mafiosi, delinquenti, persone che vivono di proventi criminosi) per limitarne libertà e movimenti ai fini della sicurezza collettiva. Ma è, ovviamente, rimasta estranea al diritto penale, che presuppone un “fatto” e che non può arrivare a colpire opinioni, modi di essere, manifestazioni del pensiero, siano pur esse malvagie, inurbane o puzzolenti.
La proposta di legge sulla c.d. “omofobia e transfobia”, prevedendo nuove ipotesi incriminatrici, oltre agli “atti di discriminazione per motivi d’odio razziale, etnico, nazionale o religioso”, inserendo anche “l’orientamento sessuale e l’identità di genere”, finisce quindi per aggiungere a questa lista un’altra infornata di Täterschulden.
Colpire una “discriminazione” – e questo vale per qualsiasi categoria “discriminata” – significa colpire atteggiamenti, modi di essere, decisioni che fanno parte della vita quotidiana; quante volte nei nostri rapporti sociali, anche i più elementari, come andare al ristorante o dal barbiere o a fare la spesa, dobbiamo operare una scelta? E questa può anche dipendere da chi ci troviamo davanti.
Se io decido, e lo dichiaro apertamente, di andare a mangiare in una trattoria italiana, piuttosto che in un ristorante cinese, perché preferisco la nostra cucina, non è già quella una sorta di “discriminazione” fondata sull’appartenenza nazionale? E, per passare a cose meno banali, se io affermo la mia contrarietà a che mia figlia si accasi con un islamico, poiché temo per l’educazione che lui vorrà imporre ai loro figli, non cado in un’altra “discriminazione” fondata sull’appartenenza religiosa?
A rigore lo sono entrambe, poiché “discriminare” significa letteralmente “distinguere, separare, fare una scelta” – e solo la guerra delle parole stravinta dal pensiero progressista ha trasformato quel verbo innocuo nell’icona semantica del male assoluto – e se tale scelta si fonda su “motivi d’odio”, allora la norma dovrebbe trovare applicazione.
Casi-limite, paradossali, estremi? No, perché è proprio attraverso il paradosso che si giunge alla verità. Se le premesse sono corrette, ogni logica conseguenza deve confermare la bontà della premessa; e la previsione, sotto questo profilo, appare infausta.
Chi potrà stabilire, allora, se la mia “discriminazione” si fonda sull’“odio” (ché solo in questo caso sarebbe punibile) e non già su questioni scientifiche, etiche, storiche o, più banalmente, di gusti personali?
Un giudice chiamato a ciò non potrebbe quindi ricavare la soluzione se non dall’atteggiamento generale, dal modo di essere, dall’appartenenza culturale e politica della persona chiamata a risponderne.
Come una serva che spia dal buco della serratura della coscienza di ognuno di noi.
Se uno è di tendenze “neofasciste/reazionarie/sessiste/cattoliche-conservatrici”, sarà evidente allora, ça va sans dire, che la sua “discriminazione” è stata dettata dall’odio. Ovvio, no?
Täterschuld.
P.S.
E Oltretevere che si dice?
Un cattolico non deve forse odiare il peccato? Non è forse l’omosessualità un peccato (addirittura uno di quelli che grida vendetta al cospetto di Dio) per la dottrina bimillenaria immodificabile stabilita da Gesù Cristo?
Il Vaticano, impegnato a benedire tutte le migrazioni, salvo dimenticarsi delle persecuzioni subite dai fedeli in tutto il mondo e della progressiva scristianizzazione delle società europee, invece di insorgere con forza contro questo attentato al diritto di libertà religiosa – ché anche di questo si tratterebbe – si è limitata a un debole miagolio; ossia che non è necessaria una nuova legge, ma piuttosto occorre applicare le norme già vigenti e promuovere l’educazione al riconoscimento della dignità di ogni persona.
Prendiamone atto, una volta per tutte: la parola “ruggire” non fa più parte del suo vocabolario.