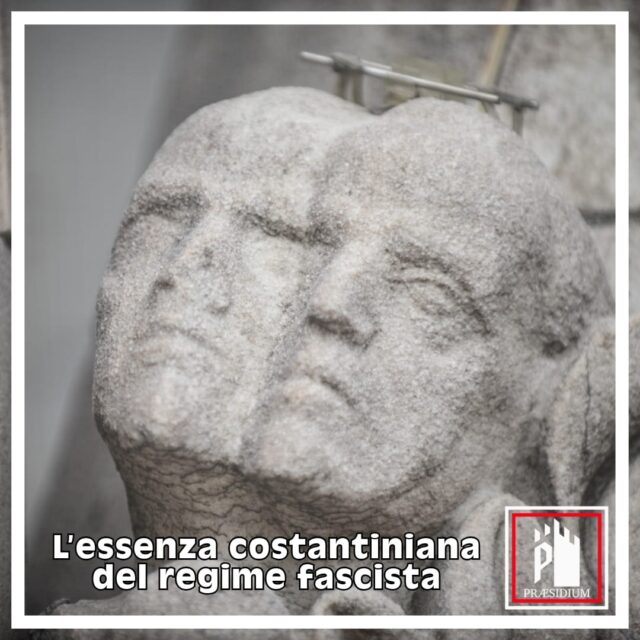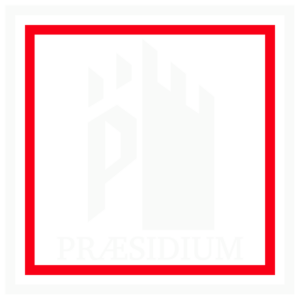Il 18 maggio 1925 il parlamento italiano deliberava lo scioglimento delle società segrete.
L’Italia fascista sanciva la sua completa alterità rispetto alla massoneria, nemica della religione cattolica e del popolo italiano. È innegabile che questo fu uno dei fatti che più determinarono la convergenza e quindi l’alleanza fra la Chiesa romana e il regime fascista, nonché la complementarietà fra il Cattolicesimo e il pensiero e l’opera del Duce.
Non a caso, poco prima dei Patti Lateranensi, L’Osservatore Romano (14/10/1928) avrebbe riconosciuto che
“è merito del Fascismo aver coraggiosamente superata la mentalità massonico-radicale e aver cominciato nella scuola, nella legislatura penale, in una parola nella vita pubblica a restituire a Dio e alla Chiesa sua ciò che loro appartiene”.
La Santa Sede, pertanto, davanti al bivio fra il clericalismo di Sturzo e De Gasperi e il fascismo optò chiaramente per quest’ultimo: Pio XI, infatti, tra il perfettismo neo-spiritualista e maritainiano dei popolari e il realismo mussoliniano scelse il secondo.
Mussolini fu “uomo della Provvidenza” non per impersonare improbabili avatara o unti del Signore, come avrebbero preteso certi ambienti esoterici (di allora ma anche di oggi), ma semplicemente, laicamente, per ricoprire il ruolo, che la Chiesa cattolica comprese essergli assegnato, di kathécon, di colui che trattiene le forze della sovversione.
Qui sta il significato dell’inconfutabile alleanza fra regime fascista e Cattolicesimo.
E qui si colloca l’essenziale dimensione costantiniana in cui il fascismo provvidenzialmente si inquadrò: è forse un caso che la Marcia su Roma (1922) e la vittoria di Costantino a Ponte Milvio (312) rechino la stessa data, il 28 ottobre, e che lo stesso mese di febbraio veda il loro secondo atto, la loro logica e morale prosecuzione, rispettivamente la Conciliazione (1929) e l’Editto di Milano (313)?
Il filosofo e giurista cattolico Carlo Francesco D’Agostino, recentemente scomparso, ha a ragione sostenuto che, mediante il Concordato del 1929, il regime di Mussolini:
ammise la subordinazione della società politica ad una legge superiore, e quindi ad un più alto legislatore, che è, poi, quello che del vincolo sociale tra eli nomini, e di questi medesimi, ideatore ed autore.
Contro il risorgimento massonico e più in generale, tutta la sovversione moderna, che aveva rifiutato l’ordine costantiniano proprio della Cristianità e la sottomissione dell’ambito etico-politico alla verità cristiana, Mussolini volle incarnare nuovamente la figura dell’optimus princeps che governa in base ai principi della tradizione politica che ebbe in san Tommaso il suo vertice speculativo: il bene comune, la tranquillità dell’ordine furono i suoi riferimenti e obbiettivi.
Giustamente lo stesso D’Agostino, che pur non fu mai fascista, ha lasciato così scritto:
Benito Mussolini fu l’unico uomo politico italiano del primo secolo di vita nazionale unitaria che sia stato animato dal sincero ed esclusivo intento patriottico, di servizio, cioè, del suo popolo. Con i suoi errori pagò lo scotto di non aver penetrato la “Somma di verità”, insita in quel medesimo Cattolicesimo cui seppe voler essere deferente, per grande merito della sua mancanza di spirito settario.
Il paragone fra Costantino, che trasforma in cristiana la Roma pagana, e Mussolini, che chiude, di fatto rinnegandolo, il periodo di dominio neopagano della massoneria, per rendere, secondo le parole di Pio XI, “Dio all’Italia e l’Italia a Dio” non è solo una congettura a posteriori, ma fu decisamente formulato da diversi esponenti della Chiesa di allora.
L’esempio forse più evidente e per il clima e la mentalità attuali più clamoroso, è forse quello dell’arcivescovo di Milano, cardinale Ildefonso Schuster, il quale non solo volle inserire fra le guglie del Duomo ambrosiano il ritratto scultoreo di Mussolini, ma proferì,all’indomani della conclusione dell’impresa etipica le seguenti parole:
Dio ha voluto dare anche al Duce un premio che ravvicina la sua figura storica agli spiriti magni di Costantino e di Augusto, recingendo, per opera di Benito Mussolini, Roma e il Re di un nuovo rigoglioso lauro imperiale. E mentre Pio XI invia fino ai confini del mondo i missionari, le legioni italiane occupano l’Etiopia per assicurare a quel popolo il duplice vantaggio della civiltà imperiale e della fede cattolica nella comune cittadinanza di “quella Roma onde Cristo è romano”.
Ma ancor più alti riconoscimenti avrebbero premiato l’opera politica mussoliniana: se già Pio XI nella sua enciclica Quadragesimo anno, elogiò di fatto l’ordinamento socio-economico fascista, condannando invece il liberalismo e l’imperialismo internazionale del denaro da una parte e il comunismo intrinsecamente perverso dall’altra, il suo successore Pio XII, nella Summi catus del 1939, lodò la diletta Italia:
fecondo giardino della fede piantata dal Principe degli Apostoli, la quale, mercé la provvidenziale opera dei Patti Lateranensi, occupa un posto d’onore nel rango degli Stati. Da quei Patti ebbe felice inizio, come aurora di tranquilla e fraterna unione di animi innanzi ai sacri altari e nel consorzio civile, la pace di Cristo, restituita all’Italia.
Nell’immane tragedia che di lì a poco seguì, lo spirito costantiniano non venne meno fino all’ultimo, se è vero che anche la repubblica necessaria di Salò rimase fedele, nonostante le ritornanti resistenze movimentiste e cripto-massoniche, al principio della cattolicità dello stato, sancita dall’articolo 6 del Manifesto di Verona: “La religione della Repubblica e la cattolica apostolica romana”.
Pertanto la R.S.I. fu l’ultimo stato cattolico italiano, fu l’estrema propaggine di quello spirito costantiniano poi rinnegato dai nuovi padroni dell’Italia, comunisti, azionisti e democristiani. Il frutto di tale rinnegamento è sotto gli occhi di tutti.