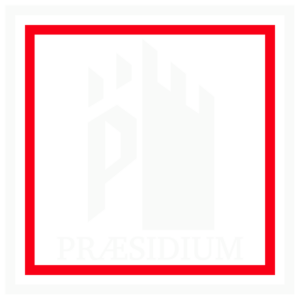L’inglorioso 2021, in Italia, si è concluso con un provvedimento largamente passato sotto silenzio ma non privo di profonde implicazioni.
Con un tratto di penna si sono vietati gli allevamenti di animali da pelliccia, un colpo praticamente mortale per un settore – per carità, piccolo e marginale quanto si vuole – che eppure rappresentava una grande eccellenza e una lunga tradizione tipicamente italiana.
Certo, il provvedimento avrà guastato l’esistenza di qualche allevatore, di qualche pellicciaio e delle relative famiglie, alla fine una manciata di individui, volete mettere col pensiero della gioia di un furetto libero nei boschi?
Vogliamo forse comparare l’amarezza di questi allevatori e pellicciai, bestie della Terra, con la gaiezza dello sguardo presente sul viso del tenero visone una volta udita la felice notizia?
E qui iniziano i problemi per una mente pensante.
Se il dramma di un uomo, per quanto uno e solo possa essere, è effettivamente un dramma, si può definire tale la vicenda esistenziale del visone e del furetto impellicciati? Per successione logica: si possono definire “drammi” la caduta del fagiano abbattuto dalla doppietta del cacciatore, il contorcersi dell’aragosta finita in pentola per il cenone di Capodanno, la fine della corsa del cinghiale sotto i colpi di un sovrapposto, il rantolo del toro trafitto nell’arena?
La risposta è ovviamente no, perché non vi può essere dramma senza coscienza e senza autocoscienza.
Per quanto sorprendente possa risultare per certuni, la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della chiusura degli allevamenti di visoni non solo non ha reso il mondo un posto migliore (per quanto la mens del legislatore fosse precisamente quella), ma non ha reso per nulla migliore neanche l’esistenza dei visoni scampati all’impellicciamento.
Nessuna coscienza di sé, nessuna coscienza di mutamento del proprio status giuridico, nessun mutamento della propria condizione esistenziale.
D’altra parte, quale gioia o quale dolore può toccare un’esistenza, quando questa è ignara del proprio stesso esistere?
Il viso o il volto sono umani, segnati più o meno tragicamente dal dramma di appartenere al genere umano; genere capace di concepire sé stesso e l’immensità dell’universo e di vivere allo stesso tempo nella melma, sospeso, come direbbe Pascal, tra l’esser angelo e l’essere bestia, equilibrista su una sottile linea tra due diversi gradi dell’essere.
Viceversa, il muso è solo quello dell’animale, per definizione mutuo e ignaro del dramma dell’esistere.
Certo che questo muso può essere anche appagato o non appagato secondo quelli che sono i propri istinti sensitivi. Per similitudine, certamente si può dire il cane che scodinzola festoso al buon padrone sia “felice”, mentre sempre per similitudine si può dire il cane avvilito e maltrattato sia “infelice”, ma entrambi questi stati non varcano la soglia sconvolgente della vita intelligente, autocosciente: non varcano la mera reazione agli stimoli sensibili che abbiamo dato all’animale.
Gli occhi di una bestia, anche di una povera e buona bestia, restano e resteranno sempre inesorabilmente vuoti.
Vuoti, ancor prima di uno sguardo sul mondo, vuoti di uno sguardo su di sé.
Fa quasi spavento, quindi, cercare di indagare le ragioni per le quali così tanti si identifichino così tanto, oggi, con le bestie.
Oggi, infatti, non dilaga forse il veganesimo, che ormai soppianta il vecchio e reazionario vegetarianesimo? Non si viene additi come “disumani” (magari proprio come “animali”?) se si esprimono apprezzamenti per l’ars venandi o per quella quella grandiosa messinscena, quella prosopopea di vita e morte che è la corrida? non si estende il diritto anche agli animali, facendone implicitamente persone giuridiche, tutelate da abusi, maltrattamenti, sperimentazioni, etc… proprio come (o anche più) si fa con gli esseri umani?
Viene da chiedersi il perché di tutto questo.
Si estende così, nel fondo del cuore dell’uomo che non è della schiera di quelli “che la ragion sommettono al talento” (qualunque aggravio di sensibilità il talento stia qui a rappresentare), un tragico sospetto.
Che il sentimento di pietà, che è chiaramente alla base di tutte le commozioni animaliste, di tutte le feroci invettive verso chi non avrebbe un animo abbastanza nobile per condividerne gli accorati spasmi, di tutte le leggi e leggiucole promulgate per propiziare il sorgere del sole dell’avvenire di un mondo di bontà e di assenza del dolore, non nasca forse dal sentimento dell’empatia, di una viscerale empatia che si prova tra sé e l’animale? Tra il cosciente e l’incosciente? Tra la forza intelligente e la forza bruta?
Fin troppo facile indovinare che la risposta è affermativa, fin troppo facile accorgersi che è l’empatia il talento cieco, irragionevole e invincibile, che promuove l’assimilazione dell’uomo all’animale.
Da cui inquietarsi ancor più largamente, se ci si interroga su cosa significhi provarla, questa empatia.
Significa stimare l’essere umano animale tra gli animali, significa abdicare alla pretesa superiorità assiologica e ontologica che l’essere umano ha, dalla notte dei tempi fino ad oggi, sentito intimamente come propria.
Significa non cogliere che vi sia una dignità, differente e superiore, tra intelligenza e sensazione, tra ragione e istinto, tra astrazione e stimolo, tra contemplazione e digestione, tra spirito e materia.
Significa non cogliere che vi sia un ordine nelle cose, “est modus in rebus”, significa che non vi siano delle gerarchie in questo cosmo, che si possano porre delle differenze qualitative ma solo quantitative.
Andando più in là, si potrebbe anche vedere la profondità del saltus che separa uomo e animale (e vegetale ovviamente), pure in maniera più radicale.
Seguendo Aristotele si potrebbe anche considerare che, secondo la sua dottrina della causalità, delle cause la principale è sempre la causa finale.
Per dire della natura di una cosa, non si dice mai abbastanza se non rispondendo alla domanda “per che fine, per che scopo è questa cosa?”
Qui si riapre, di nuovo, il dramma della condizione umana, poiché di tutti gli enti la domanda diviene realmente pressante per l’uomo. A che scopo l’essere e l’agire dell’uomo? A che fine la sua intelligenza?
Il filo d’erba è perfettamente realizzato nel suo fine di nutrimento una volta masticato dalla vacca al pascolo, questa, a sua volta, nella sua muta e ignara esistenza, può dirsi perfettamente realizzata una volta munta; ma l’uomo?
In che modo l’uomo può dire di aver raggiunto la propria causa finale? In che modo l’essere umano può dire realizzata la propria esistenza?
Può farlo restando nell’ambito della pura natura, ovvero sullo stesso grado dell’animale?
Può farlo soddisfacendo, con qualche grado di complessità maggiore, una serie articolata di istinti sensitivi?
Tutta la massa dei nostri contemporanei che prova empatia per gli animali direbbe sicuramente di sì e anzi ormai non solo sono abbracciate tale tesi, ma sono anche incapaci di immaginare nulla di diverso.
Alla fine, questa è la condizione propria dello spirito della nostra modernità. Alla fine, è questo ciò contro cui si scagliava Thomas Mann scrivendo “Considerazioni di un impolitico”, quando descriveva la vita dell’uomo occidentale democratico, imbottita di buoni propositi progressisti, simile a quella di “una vacca al pascolo”: “La sua untuosa nobiltà d’animo, la sua devozione compiaciuta ripugneranno a un uomo schietto, non solo perché egli capisce che la ‘felicità’ assicurata da tale illuminato messaggio è irraggiungibile, ma anche perché come ‘felicità’ gli sembra tutt’altro che desiderabile, anzi, del tutto indegna dell’uomo, in contrasto con lo spirito e con la cultura, ruminante e pacifica come mucche al pascolo e fondamentalmente senza anima”[1]
“Fondamentalmente senz’anima”, ecco l’espressione chiave. L’uomo “fondamentalmente senz’anima” che con i “valori” dell’“illuminato messaggio” ha reso la propria vita “ruminante e pacifica come mucche al pascolo” (francamente vengono proprio in mente tanti nostri contemporanei, specialmente giovani), sarà senz’altro pronto a sperimentarla, a viverla intimamente questa empatia con l’animale che come lui vive nella pura natura, in contrasto “con lo spirito e con la cultura”.
Che felicità può ricercare dunque l’uomo, che tensione teleologica può intraprendere quindi per essere al di sopra dell’animale? Qui si apre un bivio.
L’uomo illuminato dalla Divina Rivelazione direbbe prontamente: Dio, “il ben dell’intelletto”, la conoscenza (felicità somma, sempre per Aristotele) dell’Essere che è al contempo intelligenza e ragione somma.
L’uomo non illuminato dalla Divina Rivelazione cadrebbe invece nell’assurdo, nella lacerante condizione di disporre di una facoltà intellettiva che resterà frustrata in eterno, la facoltà di avvertire un’esigenza di ragion d’essere assoluta, per sé e per il mondo, inappagata e insoddisfatta.
Ne “Al Culmine della Disperazione”, Emil Cioran, autore radicalmente nichilista, chiaramente ispirato dal gelido soffio di Nietzsche, virilmente e senza fronzoli, assume la seconda ipotesi.
L’ipotesi di un mondo senza senso, dell’esistenza umana senza fine alcuno, senza l’illusione che qualche pseudo-morale o qualche palingenesi politica o null’altro di simile possa colmare il vuoto di Dio.
L’assurdo radicale come unica prospettiva del dramma umano, così irrimediabilmente volto alla tragedia.
Senza ovviamente voler sottoscrivere tale visione – radicalmente, quasi per autodefinizione, assurda e perciò irrazionale e impossibile – bisogna pur ammettere che anche tale prospettiva lascia una vestigia della grandezza della dignità umana, la lascia come un impero caduto lascia rovine dietro di sé, ma le lascia, a differenza dei nostri tempi di empatia per furetti e visoni che ci lasceranno hamburger di soia e giacconi sintetici.
“Sono sempre più convinto che l’uomo è un animale infelice, abbandonato nel mondo, costretto a trovarsi una modalità propria di vita, quale la natura non ha mai conosciuto […] E allora non mi stupisce che giunga talvolta ad invidiare un fiore o una pianta. Poter vivere come una pianta, crescere radicati, sbocciare e appassire sotto il sole nell’incoscienza più perfetta, fare intimamente parte della fecondità della terra, espressione anonima del corso della vita, bisogna disperare del senso dell’umanità. Allora perché non cambio la mia esistenza con quella di un fiore? […] Certo, essere un uomo è una cosa immensa; una delle più tragiche, un dramma enorme, perché significa vivere in un ordine di esistenza del tutto nuovo, più complesso e drammatico di quello naturale. A mano a mano che si scende verso la natura inanimata, il fenomeno drammatico si fa meno intenso, fino a scomparire. L’uomo tende sempre più a detenere il monopolio del dramma e della sofferenza nel mondo. Ecco perché la salvezza rappresenta per lui un problema così bruciante e così insolubile.” [2]
Per quanto si voglia credere nell’infelicità ultima del destino umano, ecco come Cioran evidenza l’incommensurabile differenza tra vita umana e vita incosciente.
Da una parte la serenità dell’incoscienza perfetta, dall’altra l’uomo, posto oltre le comuni modalità della natura col suo problema della salvezza.
Sia che si consideri il problema della salvezza solubile o insolubile, bruciante o pacificante, non si può negare che nell’uomo è la grandezza di tale problema.
Non si può negare che nella serena quietezza del vegetale o dell’animale invece tale problema non vi è posto.
L’empatia dell’uomo verso l’animale (e non viceversa) nasce perciò dalla sconvolgente rimozione non solo della risposta a tale domanda, ma dalla domanda stessa.
Non si può negare che nell’odierna diffusione dell’anti-specismo – unica logica conclusione di qualunque animalismo – vi è lo scivolamento dell’essere umano dal suo “ordine di esistenza del tutto nuovo, più complesso e drammatico di quello naturale” ad una condizione per la quale le nostre presenze non sarebbero che una “espressione anonima del corso della vita”.
[1] T. Mann, Considerazioni di un Impolitico pp. 266 – 267
[2] E.M. Cioran, Al Culmine della Disperazione pp. 81 – 82