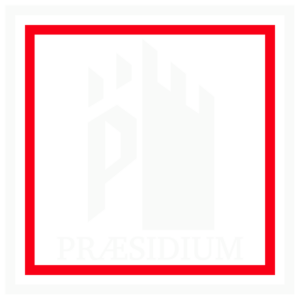“Historia magistra vitae” recita un celeberrimo detto ciceroniano. Così, per i difficili problemi dell’oggi, è forse utile guardare, di tanto in tanto, ai grandi esempi del passato, e oggi, senza dubbio, un grande tema è quello posto dalla convivenza di diversi popoli nella vecchia Europa, portati qui dal grande fenomeno migratorio iniziato negli ultimi decenni.
A questo riguardo, sono costanti due diverse linee direttrici, spesso differenziate dalla loro origine rispettiva a destra e a sinistra, entrambe tuttavia spesso rivolte allo stesso obiettivo: come ottenere una migliore integrazione.
Così, da sinistra si sente spesso che per integrare i nuovi arrivati sul continente europeo gli si dovrebbe aprire le braccia, concedergli facilmente diversi diritti, come il diritto di voto, facilitare il loro accesso alla cittadinanza, preferire lo ius soli al più discriminatorio ius sanguinis. In generale, poi, si ritiene, in nome dell’eguaglianza, che non si debba richiedere un adeguamento, nei casi in cui questo possa essere percepito come restrittivo, ai costumi e alle tradizioni di chi arriva nei paesi europei.
Viceversa, da destra si domanda invece che gli stranieri integrandi debbano necessariamente rinunciare ai propri usi, costumi, tradizioni e conformarsi in tutto e per tutto alle concezioni proprie della nazione ospitante.
Si potrà facilmente vedere come entrambe queste prospettive fossero estranee alla mentalità romana, che fu capace di reggere per secoli un dominio ben più vasto e complesso di quello esercitato dalle odierne cancellerie d’Europa.
Proviamo allora, per un attimo, ad entrare, per sommi capi, nel mondo di Roma antica.
In primo luogo, va ricordato che la mentalità romana, pur forgiata dalla sua origine agreste e, perciò, assolutamente pragmatica, riteneva il proprio dominio di natura sacra e la Patria romana era investita di una particolare missione divina. In questo contesto l’imperium romano era imperium sine fine, un potere senza fine nel tempo e nello spazio, concesso direttamente da Giove con questi caratteri a Roma.
Già da questo vediamo come sia differente la prospettiva: oggi la politica è abbassata dal secolarismo e dalla laicizzazione del costume e delle istituzioni ad un ordine sempre più amministrativo-contingente, e perde progressivamente la capacità di concepirsi a grande respiro. Il massmediatismo delle democrazie moderne impedisce di vedere oltre il problema dell’oggi e determina l’azione politica ora sull’emergenza, ora sul sentimento, ora sull’interesse economico di breve termine (dove per breve termine, secondo l’ottica romana, sono anche i programmi moderni più ambiziosi, impostati su prospettive al più decennali).
Per il mondo romano non dovrà stupire, per fare un esempio, che i primi senatori accettati nella curia dalla provincia della Gallia Narbonense siano comparsi sotto il principato di Claudio, ossia dopo più di due secoli di intensa romanizzazione della regione, e pure in ogni caso con forti resistenze dello stesso Senato, come attestato da Seneca nell’Apocolocyntosis, l’opera satirica e denigratoria rivolta da Seneca a Claudio anche per la sua molto mal vista politica aperturista.
Su questa scia, possiamo allora anche criticare un’altra idea molto diffusa da una certa volgarizzazione della storia romana, ossia quell’idea che Roma sarebbe stata sempre aperta verso i nuovi popoli, verso lo straniero, verso gli assoggettati, e che proprio questa sarebbe stata la cifra della sua tendenza universale; radicale smentita quindi del modello delle piccole polis greche, chiuse nel proprio particolarismo incapace di integrare non solo il barbaro, ma anche lo stesso greco, nel caso fosse di diversa origine cittadina.
Si citano in genere, al riguardo, le origini stesse di Roma, fondata presumibilmente per sinecismo di piccole diverse comunità dell’agro laziale. In particolare, l’arcaica ripartizione della città in tre tribù, i Ramnes, i Titienses e i Luceres, dovrebbe rispecchiare i tre diversi popoli di origine ossia i Latini, i Sabini e gli Etruschi.
Si aggiungono poi i diversi casi di integrazione permessi da Roma verso gli stranieri, come nella prima epoca repubblicana quella celebre di Appio Claudio, integrato dalla Sabinia nel Senato, e di tutta la sua gens, con tutti i suoi parenti e tutti i suoi clientes, fino a circa cinque mila membri.
Come detto, però, quest’ottica è fortemente criticabile e appare ampiamente incompleta, specie se volta a giustificare una politica aperturista e integrazionista sul modello di quelle prospettate oggi.
I romani infatti, in primo luogo, distinguevano, in qualunque comunità e popolazione, il populus dall’ordo, rientrando nel primo la massa degli abitanti della comunità, nel secondo l’élite, l’aristocrazia chiamata a reggere e governare i primi; il tutto, perciò, a immagine del modello della vita civile di Roma, retta innanzitutto dal ruolo centrale dell’assemblea aristocratica del Senato, di cui poi anche l’imperatore farà parte, essendo anzi imperatore, o meglio princeps senatus, proprio perché primo membro dell’assemblea senatoria.
A questo proposito, bisogna quindi dire che Roma riteneva integrabili non certo i popoli, ma solo le élite di essi, non vedendovi nessuna utilità, né tanto meno nessun dovere da parte di Roma al riguardo.
L’integrazione delle élitè provinciali si compiva tramite la concessione della cittadinanza, le concessioni viritiane, il cui giudizio era sempre appannaggio dell’Imperatore, escludendo quindi qualunque meccanismo automatico di acquisizione. Questa concessione era poi, senza dubbio, il completamento di un lungo percorso, non solo individuale ma intergenerazionale, visto che perché si potesse giudicare a favore della concessione era necessario un alto grado di romanizzazione e di fedeltà a Roma, della persona come della famiglia e della stessa provincia di provenienza; è totalmente escluso, quindi, che la concessione potesse essere fatta per favorire o per auspicare o per agevolare l’integrazione, come invece viene oggi suggerito di fare verso gli stranieri.
All’inverso, veniva concessa in province mansuete verso il governo di Roma, altamente latinizzate, le cui élite si erano mostrate cooperative verso i magistrati romani (per far accedere una domanda di naturalizzazione a Roma era necessaria infatti, quanto meno, una lettera di un magistrato romano provinciale che perorasse la causa), distintesi, ad esempio, nella devozione del culto all’imperatore.
Anche sul culto si possono fare utili osservazioni. Molto spesso, infatti, si vede nel Pantheon romano un altro grande slancio di apertura, il desiderio romano di integrare al suo interno qualunque culto e qualunque divinità per farla immediatamente propria. Eppure le cose non stanno così. In primo luogo, va riconosciuto che la religiosità antica e pagana era tanto ritualistica e formalistica, una religione strettamente sacerdotale, quanto estranea ai concetti di divinità personali e trascendenti, confondendo quindi le forze del mondo naturale, o le misteriose forze del sovrannaturale, con le persone divine del proprio culto.
Perciò, non era assolutamente scandaloso associare alle proprie divinità, ad esempio, della luce o solari altre figure analoghe provenienti da culti stranieri. Al tempo stesso, però, va ricordato che i collegi sacerdotali romani furono sempre esclusi ai non cittadini e i quattro collegi maggiori appannaggio quasi esclusivo dei soli patrizi. Come sempre, poi, Roma si sentiva libera di rifiutare un culto straniero, come dimostrato da Catone il Censore per i culti dionisiaci di origine greca o come testimonia l’eterna ostilità romana verso i giudei e poi verso gli stessi cristiani, i quali, pur obbedienti verso l’autorità romana, non sacrificando all’imperatore risultavano facilmente oggetto di segregazione e persecuzione.
La concessione della cittadinanza non era comunque mai un fatto facile o disponibile a buon mercato. Inoltre, va ricordato che la cittadinanza si trasmetteva di norma esclusivamente per ius sanguinis e mai per ius soli, almeno fino alla decadenza dei Severi e alla Constitutio Antoniniana di Caracalla, sulla quale, comunque, ci restano giudizi sistematicamente negativi da parte delle fonti antiche.
Sconosciuto era poi al diritto romano il concetto di doppia cittadinanza. L’unica speranza per i provinciali non aristocratici di divenire cittadini era il servizio nelle legioni, che formalmente riservavano l’arruolamento ai cittadini, lasciando agli stranieri solo i posti nelle truppe ausiliarie (fanterie e cavallerie leggere, arcieri, frombolieri, etc..), ma che nei fatti, particolarmente nei periodi di guerra per le stringenti necessità, arruolavano stranieri, concedendogli poi, a fine servizio (un servizio duro, di circa venticinque anni), l’agognata cittadinanza.
Si capisce quindi che valore avesse la cittadinanza romana e in che posizione gerarchica si trovasse. In tale gerarchia degli statuti delle persone, bisogna così mettere all’apice il cittadino di diritto romano, poi quello di diritto latino, il quale è escluso dalla vita politica romana, ma vanta lo ius nubendii e lo ius commercii, ossia il diritto di sposare legittimamente cittadini romani (l’unione di cittadini romani con stranieri era, invece, formalmente e legalmente nulla, considerata alla stregua di un concubinato) e di commerciare con essi con piena validità giuridica. Gli stessi cittadini latini erano poi divisi tra i maggiori e i minori o giuniani, dove i detentori del Latium Maius, il diritto latino maggiore, avevano la facoltà di poter venire in futuro romanizzati, mentre i giuniani avevano preclusa questa prospettiva.
Seguivano poi i peregrini, ossia gli stranieri propriamente detti, tra i quali figuravano quindi la gran massa e le élite, delle province, i peregrini diditizi, ossia gli stranieri di popolazioni vinte particolarmente riottose o arretrate, a cui non era garantita alcuna personalità giuridica (quella dei deditizi era perciò la peggiore libertà, visto che costoro, ad eccezione appunto della libertà, non avevano quasi nessun altro diritto riconosciuto), e infine gli schiavi. Categoria a sé erano i liberti, ossia gli schiavi liberati, che data l’antica condizione servile quasi mai potevano poi accedere allo status di cittadini, se non per i liberti resi tali da padroni direttamente residenti nell’Urbe. Nella maggior parte dei casi, divenivano comunque deditizi, o al più latini giuniani.
Ognuno aveva perciò il proprio diritto dettato dalla propria personalità e tale lo conservava, in una quadra di sostanziale quanto formale ineguaglianza, ovunque si trovasse, a Roma, in Italia o in una provincia.
Così, anche le comunità, le civitas (i centri urbani con i relativi contadi), avevano i propri statuti particolari. Si va in ordine dalle civitas che potevano vantare l’ambitissimo e il molto poco concesso ius italicum, per il quale la città era considerata parte integrante dell’Italia e perciò pienamente romana ed extraterritoriale rispetto alla regione in cui si trovava localizzata, ai municipi e alle colonie romane, ossia città di cittadini romani, dipendenti direttamente da magistrati romani, con istituzioni ricalcanti quelle di Roma, alle colonie latine e alle città peregrine, a loro volta divise tra stipendiarie, ossia soggette al pagamento di un tributo specifico a Roma, libere, ossia città alle quali l’imperatore concedeva l’esenzione dal tributo, o federate ossia città che formalmente non facevano parte della provincia romana e non erano soggette al suo governatore, in quanto erano state alleate di Roma e con essa teneva rapporti sanciti e regolati da un trattato formale.
In ogni caso, va ricordata, come detto, la personalità del diritto: ad esempio, un peregrino residente in una colonia romana restava ovviamente peregrino e in quanto tale estraneo al resto della comunità, e non poteva considerarsi in un rapporto di eguaglianza verso un cittadino romano.
Per dare un’idea di cosa significasse questa distinzione giuridica si può osservare il noto caso processuale di San Paolo, il quale, vantando la propria cittadinanza romana, domanda e ottiene di essere sottratto al tribunale giudaico e di poter esser giudicato da romani. Il suo racconto suscita lo sconcerto dei magistrati romani, quando riferisce di essere stato oggetto di torture e maltrattamenti. Domanda e ottiene, poi, di poter appellare la sentenza a un tribunale dell’Urbe, prassi obbligatoria per le sentenze di morte rivolte contro i cittadini ma appannaggio solo dei cittadini romani di pieno diritto, potendo i peregrini appellare solo fino al governatore provinciale. A San Paolo si commina, infine, quando la condanna viene confermata, una morte incruenta.
Dallo stesso episodio possiamo poi dedurre un altro fatto: Roma non esigeva la soppressione delle autorità e dei tribunali locali. Allo stesso modo, non pretendeva né che le popolazioni provinciali si assimilassero né che si sostituisse alla loro amministrazione e alle loro giurisprudenze tradizionali il costume o l’amministrazione romana.
Il governatore romano di una provincia di norma non si occupava quindi di curarsi degli affari specifici di una comunità, lasciando che fosse questa, tramite le proprie istituzioni interne, ad autogestirsi. Interveniva se lo imponeva una necessità particolare, a coordinare la riscossione dei tributi, a tutelare lo status dei cittadini, a ricevere gli appelli dei tribunali, a risolvere le controversie delle diverse città come responsabile dell’autorità militare. Tutto ciò non tanto per un malinteso intento liberale o progressista, assolutamente assente, quanto viceversa per il desiderio inverso, schiettamente conservatore, di non mischiare le popolazioni provinciali con il costume romano.
Da questa panoramica tanto incompleta del mondo romano quali lezioni possiamo trarre allora per l’oggi?
In primo luogo, come detto all’inizio, possiamo trarre che, per impostare una politica di ampio periodo e di ampio respiro, è senz’altro necessario, per qualunque nazione, sentire un senso di missione, senso che non può che essere mistico e sacrale. E che è in conformità a questo senso spirituale che si può assurgere a modello per il prossimo, fino a suscitare in esso un desiderio di emulazione.
Un’integrazione di qualsiasi tipo deve, perciò, nascere solo se domandata, con costanza, umiltà e fedeltà dall’integrando, deve essere ottenuta dopo un lungo periodo, addirittura secolare, come a Roma, se necessario. Roma ci ricorda inoltre che chi dovrà concedere il diritto di cittadinanza non può in alcun modo essere obbligato verso tale concessione, né potrà trascurare ovviamente i propri interessi in tale processo e che naturalmente essa dovrà procedere per tappe lente.
In base a questi assunti, lo ius soli, la trasformazione di un cittadino in membro di una certa comunità per il mero fatto di esserci nato o di risiederci, è una totale assurdità.
La distinzione delle persone in base al proprio status e alla propria origine si impone come necessità nei casi di convivenza tra genti di origini e costumi di distinto tipo, ed è perciò assurdo pretendere di imporre a chiunque una stretta omologazione a un costume o a una sola legislazione. E, allo stesso modo, l’autorità centrale si mantiene la riserva insindacabile di fissare e di decidere dove termini tale tolleranza.
Roma ci dice anche che il diritto non dovrebbe fare il cittadino, inventandolo come membro di questa o quella comunità per il possesso di un pezzo di carta, ma, viceversa, dovrebbe essere il diritto a generarsi dalle diverse personalità alle quali si rivolge, rispecchiandone così le differenze delle diverse condizioni.
Ci dice, infine, che è possibile concepire un vivere civile in cui si distingue il diritto della persona da quello della comunità territoriale e forse è questa, più di tutte, l’ipotesi che si dovrebbe riscoprire oggi, mentre si pone l’annoso problema di come relazionarsi con comunità straniere ormai installatesi in nazioni europee di differente tradizione.