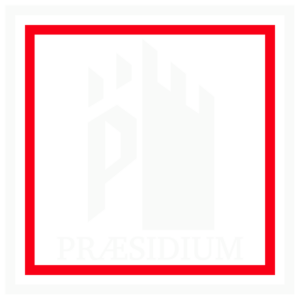PASQUA: LE DONNE AL SEPOLCRO. ESEGESI DEL VANGELO DI MARCO.
Marco 16,1-8
1 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. 2 Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. 3 Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?». 4 Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. 5 Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. 6 Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. 7 Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 8 Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura.
Gli studiosi convengono nel dire che il racconto della tomba vuota concludeva il Vangelo di Marco. I versetti che chiudono attualmente sul suo Vangelo non sono di sua mano; sono stati chiaramente “aggiunti” per eliminare la perplessità di una conclusione così brusca: la paura e la fuga delle donne dal sepolcro vuoto. Eppure, proprio questa conclusione sconcertante è piena di fecondità e ci pone negli atteggiamenti giusti di ascolto e disponibilità. Sono veramente poca cosa questi otto versetti che Marco dedica all’annuncio dell’evento che sostiene tutta la speranza cristiana. Quindici capitoli per farci seguire la vicenda di Gesù, e una piccola frase dentro un racconto scarno per annunciarci la Sua risurrezione: “Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto” (Mc16,6).
Questa sobrietà sconcertante fa parte delle intenzioni di S. Marco. Sbaglieremmo se affrontassimo la meditazione di questo racconto prigionieri di precompressioni e attese a “lieto fine”. Siamo invitati a entrare nel mistero proposto con la disponibilità totale a lasciarci sorprendere. Sbaglieremmo atteggiamento anche se cercassimo nel racconto di Marco i dati della cronologia della risurrezione. Non si tratta di un resoconto in diretta, dal vivo, ma della restituzione di un’esperienza di fede profonda maturata nella comunità cristiana, grazie a una quarantina di anni di paziente meditazione. Ne consegue che siamo invitati ad entrare nel testo non come curiosi, ma come discepoli. La strada delle sequela di Gesù, che ha ritmato tutto il Vangelo di Marco raggiungendo il suo culmine con la professione di fede del centurione sotto la croce “Davvero quest’uomo era figlio di Dio” (Mc 15,39), si conclude qui, alla tomba vuota, per riaprirsi immediatamente da capo, dalla Galilea dove era cominciata.
Per comprendere come Marco costruisce questo racconto, possiamo fare attenzione ad alcuni indizi, il primo dei quali è offerto dalla presenza dei verbi di movimento. C’è un primo acceso ad “andare” per ungere il corpo di Gesù (versetto1). C’è un “andare al sepolcro” (v.2) che caratterizza i vv. 2-4. Infine i vv.5-8 sono racchiusi dentro la segnalazione di’ “andare dentro al sepolcro” (v.5) e di un “andare fuori dal sepolcro” (v.8). Perciò il testo può essere suddiviso in tre parti: una introduzione (v.1) l’andata al sepolcro (vv.2-4) e l’evento dentro il sepolcro (vv. 5-8).
Dall’osservazione della struttura emerge come l’andare delle donne sia funzionale al loro entrare nel sepolcro e questo entrare, a sua volta, prepara il messaggio del giovane, che costituisce il centro di tutta la narrazione. L’uscita dal sepolcro con la fuga, la reazione di timore delle donne e il silenzio sono la risposta incompiuta, e quindi aperta, a quanto accaduto. Da essa siamo fortemente coinvolti come ascoltatori.
Non ci può sfuggire l’importanza e il ruolo che Marco attribuisce a queste donne, protagoniste del racconto. Esse diventano testimoni oculari negli avvenimenti centrali della Pasqua di Gesù: morte, sepoltura, annuncio della risurrezione, come documenta l’insistenza del verbo “vedere” ad esse attribuito.
Ma singolare è il modo con cui l’evangelista le introduce nel racconto. Le fa comparire per la prima volta sotto la croce di Gesù, come parte di un gruppo più numeroso di donne che stanno “a guardare da lontano”, proprio mentre i discepoli con la loro fuga hanno interrotto il rapporto di sequela (15,40). A questo punto Marco ci fa sapere che queste donne hanno attuato una sequela e un servizio a Gesù fin dagli inizi in Galilea (15,41). Esse, quindi, anche se mai nominate prima, sono sempre state presenti silenziosamente nella vicenda di Gesù, e ora diventarono protagoniste di un ruolo unico e decisivo negli eventi pasquali, in sostituzione del gruppo maschile degli apostoli e discepoli che fuggono, tranne Giovanni, unico che sarà sotto la croce.
Per Marco queste donne vengono dunque a incarnare una presenza continua e fedele al Maestro, una fedeltà ininterrotta che ora sta per esprimersi nel gesto di pietà di ungere il corpo, gesto che segnala una ricerca intensa di Gesù.
E’ chiaro che, con la presentazione della loro fedeltà, Marco ci invita ad assumerle come modello e a guardare con i loro occhi la vicenda di Gesù.
A queste donne è attribuita un’azione (“comprare degli aromi”) complementare a quella messa in atto da Giuseppe D’Arimatea (cf.15.46: “comprato un lenzuolo”). Si tratta di unguenti odorosi destinati all’unzione di salme importanti. Di fatto lo scopo dell’azione è nell’ andare a ungere il corpo di Gesù, è così posta in risalto la venerazione che le donne hanno per il Maestro. Nel contempo, però, si lascia capire che le donne rivolgono la loro attenzione ad un cadavere e che il loro orizzonte è del tutto opposto a quello che verrà loro successivamente aperto nell’annuncio pasquale.
L’intenzione di andare ad ungere un cadavere, dopo un giorno e mezzo dalla sepoltura, appare fuori luogo e rimarrà incompiuta, mettendo così in risalto che la ricerca delle donne è vana, perchè Gesù non è più un morto che si possa ungere.
Dentro il sepolcro: annuncio e reazione (vv 5-8)
“Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura.”
Il racconto raggiunge progressivamente il suo culmine. All’ingresso nel sepolcro segue la seconda connotazione visiva delle donne: “un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca”.
Molti elementi convergono ad indicare che questo giovane rappresenta un Angelo. La veste candida che lo avvolge simboleggia un vestimento celeste (cf.Dn7,9 ; Ap.3,4.5.18; 7,13) e richiama il vestito “bianco” della Trasfigurazione di Gesù (Mc 9,3). Che si tratti di un personaggio celeste lo confermerà il suo annuncio e la reazione delle donne. Il suo essere seduto rivela autorità e il posto che occupa alla destra simboleggia successo-benedizione ed induce a pensare che il suo sarà un lieto messaggio. Le donne rimangono “stupefatte”. E’ questo un motivo tipico dei racconti di manifestazioni di Dio: all’apparizione di un essere celeste, l’uomo si stupisce, colto dal senso del mistero che lo raggiunge.
“Ma egli disse loro: non spaventatevi! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto”.
Le parole dell’angelo iniziano con una formula di rassicurazione che rende disponibili i destinatari a ricevere sia suo annuncio: “non siate stupefatte”.
L’annuncio che egli dona è in sintesi il primitivo “Kerigma” l’annuncio di Cristo salvezza, dato alla comunità cristiana circa la morte, sepoltura, risurrezione e apparizioni di Gesù (1Cor 15,3-8). Ma vi sono delle particolarità che Marco ci offre nel suo racconto. In primo luogo l’angelo interpreta tutto l’agire delle donne come un cercare e come oggetto di questa ricerca è presentato il nome di Gesù qualificato da due attributi ben determinati: il Nazareno delinea la provenienza di Gesù; il crocifisso ricorda la sua fine terrena. Al pietoso ricercare delle donne è richiesto di dislocarsi altrove, di sintonizzarsi con il messaggio divino che annuncerà un inatteso incontro con Gesù risorto in Galilea (v.7). Nell’assenza del cadavere di Gesù, che costituiva l’oggetto della loro ricerca, esse sono invitate a disporsi ad accogliere un nuovo modo di presenza delle persona cercata.
Nel messaggio dell’angelo Crocifissione e Risurrezione sono accostate in forte contrasto tra loro. L’evento glorioso della risurrezione non toglie la realtà ignominiosa della croce (cf.Gal 3.13), così che all’identità piena di Gesù appartiene l’essere Crocifisso-Risorto. L’azione potente di Dio si esercita su colui che è e rimane il Crocifisso. Marco non vuole attenuare per nulla lo scandalo e la tensione che deriva dal fatto che, colui che la Chiesa riconosce come Signore vivente, è un Crocifisso. In questo l’annuncio angelico raggiunge ciò che Marco ha già espresso nel culmine del suo Vangelo con confessione di fede del centurione (15,39): nel Crocifisso si rivela il mistero del Figlio di Dio, il Crocifisso è il Risorto!
All’annuncio della risurrezione segue l’indicazione da parte dell’angelo del sepolcro vuoto: “non è qui, ecco il luogo dove lo deposero”.
La risurrezione viene presentata come un abbandono della tomba e vien indicata non solo l’assenza del cadavere, ma dell’intera persona, in perfetta consonanza con la concezione giudaica del sepolcro come luogo di permanenza non del cadavere, ma di colui che era morto. Ma attenzione, il fatto che il sepolcro sia aperto e Gesù non ci sia, non è presentato come prova della risurrezione: le donne erano già entrate nel sepolcro senza nulla dedurre sulla risurrezione. Questo è un evento che può essere solo annunciato e mai dedotto. Mostrare il sepolcro vuoto, dopo l’annuncio, diventa un segno che aiuta a capire il messaggio proclamato ed è un procedimento frequente nelle comunicazioni che Dio fa agli uomini attraverso un inviato speciale.
Reso vano il progetto di ungere Gesù, l’angelo offre alle donne un altro compito, conferendo loro una missione espressa dagli imperativi: “andate, dite” (v.7).
L’attenzione è ora spostata dal Risorto ai suoi apostoli e discepoli e in prima istanza a Pietro. Il messaggio inizia con l’espressione “vi precede in Galilea” e fa riferimento alla predicazione di Gesù in Mc 14,28 “dopo che sarà risorto, vi precederò in Galilea”. Questo Gesù che precede invita dunque a ripartire, a riprendere la sequela dopo l’abbandono della Passione. Il Risorto, dunque, non solo si concilia coi suoi, ma offre un nuovo movimento di sequela, ormai aperto ad ogni credente. Non a caso questa ripresa avviene in Galilea dove aveva avuto inizio la prima chiamata, luogo della prima evangelizzazione universale, rivolta ai giudei e pagani.
La ripresa della sequela è quindi anche ripresa da parte della comunità dei discepoli del compito di annuncio del Vangelo a tutte le genti.
“Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perchè erano piene di spavento e stupore. E non dissero niente a nessuno, perchè erano impaurite.”
La reazione delle donne (v.8), con cui si chiude il nostro testo e l’intera narrazione evangelica, è di una complessità e densità particolare. Il compito assegnato dall’angelo alle donne resta non eseguito; agli imperativi “andate e dite” si contrappongono il “fuggirono e non dissero niente a nessuno”.
Invece di un racconto a lieto fine ci si presenta un finale aperto e problematico dove gli interrogativi anzichè dissolversi si addensano. Le donne, che all’inizio ci erano state delineate come modello di fedeltà discepolare, possono considerarsi ancora tali nel loro non eseguire il mandato dell’angelo?
Che cosa determina il loro timore, la loro fuga e il loro silenzio?
Ben tre termini esprimenti paura, tremore e stupore si concentrano in questo versetto finale. Tale insistenza è ben spiegabile per il fatto che le donne si trovano davanti, con l’annuncio pasquale, al punto massimo della Rivelazione.
E’ la necessaria reazione dal punto di vista umano al primo impatto con il punto di vista divino, manifestato pienamente nell’annuncio angelico.
Questa sproporzione tra attesa e risposta dà ragione delle reazione delle donne. L’uscita e la fuga dal sepolcro vanno lette nella stessa ottica e non sono immediatamente da giudicare in senso negativo come incredulità e disobbedienza. Piuttosto il movimento di uscita e di allontanamento dal sepolcro segnala una prima modificazione dal punto di vista umano, quello delle donne. Il sepolcro non è più al centro del loro interesse perchè Gesù non è più là. Esse hanno intuito che non possono più continuare nella ricerca di una cadavere che non abita più il sepolcro. Il timore che le ha colte di fronte all’annuncio angelico ha dunque il suo primo frutto. Resta da interpretare il silenzio delle donne, l’unica azione che contravviene esplicitamente al mandato angelico.
Questo silenzio, nell’ottica di Marco, è il commento più efficace alla novità sconvolgente, alla inesauribile eccedenza dell’esperienza pasquale. Come potrà essere annunciato ad altri com parole umane ciò che supera l’esperienza umana?
L’esperienza pasquale delle donne ha dunque due effetti adeguati: il timore e il silenzio. Su questo silenzio termina il Vangelo di Marco.
Tutto il vangelo marciano non è di facile ed immediata comprensione, soprattutto per quanto mette in moto in noi ascoltatori.
Le donne che per la loro fedeltà al Maestro hanno attirato la nostra simpatia, sono ora un prezioso indicatore. La reazione di paura-stupore smorza l’entusiasmo per il lieto fine ci mette in guardia da una troppo facile precompressione dell’evento annunciato.
Il disorientamento delle donne si riverbera su chi legge come bisogno di una comprensione più profonda: non appena esse si allontanano dal sepolcro, noi siamo come ricondotti a riascoltare che cosa nella parole dell’angelo vi fosse mai di tanto formidabile e a misurare la “maggiore grandezza” della bella notizia del Nazareno crocifisso risuscitato da Dio.
Se diventa significativa la reazione di paura-stupore delle donne, ancor più provocante diventa il loro silenzio.
Questo silenzio, infatti, rimarca la differenza tra la grandezza dell’evento pasquale e la povertà della fede che lo accoglie, suscitando la necessità di un ulteriore cammino di maturazione. Il doppio tacere delle donne e di Marco che conclude così il suo Vangelo, rende il lettore pensoso e attento alla profondità inesauribile dell’annuncio pasquale. Il silenzio che chiude il racconto lo costringe a riprendere da capo e con nuova prospettiva la lettura del Vangelo e con essa la sequela, coinvolgendovi l’orizzonte della sua esistenza. Il Mistero rivelato in Cristo Gesù è eccedente ogni esperienza e ogni comprensione ed invita a riformulare i propri progetti, a farli evolvere in direzione impreviste.
Di fronte a questo dono straripante ogni discepolo è continuamente inviato a ripartire, a ricominciare a leggere il Vangelo, a riavviare la propria sequela perché solo la sequela fatta nel silenzio meditativo dischiude al dono incommensurabile di Dio e rende aperti alla sua perenne inesauribile novità.
Dalla “fuga” delle donne siamo spinti noi ad entrare nel sepolcro per ascoltare e riascoltare l’annuncio della nostra salvezza. Ci viene offerta la lieta notizia pasquale che rompe gli argini delle monotonia e sottrae la vita umana alla sia opacità. La tomba vuota e l’annuncio della risurrezione dicono ormai che, nella forma dell’umanità risorta di Gesù, Dio padre è per sempre e per tutti disponibile. Dice che il cielo non è vuoto e che Gesù in Dio sempre disponibile come Padre in questo è onnipotente: sempre in grado di ridarci la vita senza nessuno ostacolo. La vita umana non è più consegnata all’assurdo e alla disperazione, neppure al caso o alla fortuna ma ogni vicenda è custodita nella mani paterne di Dio. Il dire il vero della fede nasce sempre dal silenzio. Spesso noi pensiamo che annunciare sia soprattutto parlare. Di fatto Marco ci fa comprendere che annunciare è prima di tutto meditare: dalla contemplazione fioriranno parole che hanno sapore, che trasmettono e restituiscono vita che coinvolgono le sottrae personali e sono percepite come salvezza. L’inflazione delle parole non giova alla “Parola”.
Questa si nutre di obbediente silenzio.
Auguri a tutti noi perchè i giorni del Santo Triduo Pasquale e della S. Pasqua siano occasione di silenzio e di rinnovata sequela al Crocifisso Risorto !
Alessandro prof. dott. Tamborini
*Plenipotenziario per le politiche di tutela e promozione del patrimonio storico-artistico-Teologo, cattedratico e studioso di Scienze Religiose, Storia e Simbolismo dell’Arte Antica e Medievale
Victimae paschali laudes
Victimæ paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et Vita duello conflixere mirando: Dux Vitæ mortuus, regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis,
angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: præcedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.
Traduzione liturgica in lingua italiana
Alla vittima pasquale si innalzi il sacrificio di lode,
l’Agnello ha redento il gregge, Cristo l’innocente ha riconciliato i peccatori col Padre. Morte e Vita si sono affrontate in un duello straordinario:
il Signore della vita era morto, ora, regna vivo.
Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via?
La tomba del Cristo vivente, la gloria del risorto;
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le vesti;
Cristo mia speranza è risorto e precede i suoi in Galilea.
Siamo certi che Cristo è veramente risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. Alleluia.
Il Victimae Paschali è una sequenza che tradizionalmente viene cantata prima del Vangelo nella solennità di Pasqua e, facoltativamente, nell’ottava. La composizione, ritenuta dell’XI secolo, viene generalmente attribuita al monaco Wippone, cappellano dell’imperatore Corrado II, ma è stata anche attribuita ad altri, quali l’abate Notker Balbulus, Roberto II di Francia detto il Pio, il compositore di inni latini Adamo di San Vittore. Insieme ad altre quattro sequenze medievali Victimae Paschali Laudes è tra quelle che sono state preservate nel Missale Romanum pubblicato nel 1570 in seguito al Concilio di Trento svoltosi tra il 1545 e il 1563. Le altre sequenze sono il Dies irae, Lauda Sion (Ecce Panis), lo Stabat Mater e Veni Sancte Spiritus. Le cinque sequenze sono state ancora mantenute dalla riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II ed attualmente in uso nella Chiesa cattolica. Precedentemente al Concilio di Trento le sequenze erano numerosissime, molte chiese locali e molte festività religiose avevano una propria sequenza e per la festività Pasquale c’erano addirittura 16 differenti sequenze. Il testo di questa sequenza venne musicato a cominciare dal canto gregoriano, da molti compositori del Rinascimento e del Barocco, tra cui Antoine Busnois, Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Adrian Willaert, Hans Buchner, Giovanni Pierluigi da Palestrina, William Byrd e Lorenzo Perosi.
Iconografia